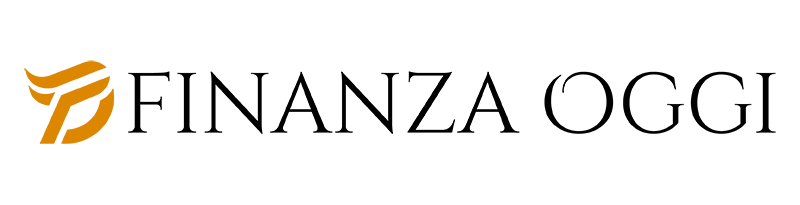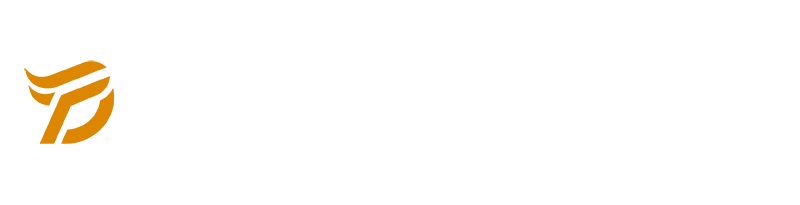Il quadro tracciato dal nuovo rapporto
Un’analisi condotta dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, in collaborazione con la CIDA, ha messo in luce una dinamica che da decenni caratterizza il sistema previdenziale italiano: la svalutazione delle pensioni medio-alte. Secondo il rapporto, la combinazione di nuove norme contenute nella Legge di Bilancio 2024 e l’ondata inflazionistica del biennio 2023-2024 ha avuto effetti pesanti sugli assegni pensionistici superiori a 2.500 euro lordi al mese, ridotti in molti casi a poco meno di 2.000 euro netti. Nel lungo periodo, la mancata rivalutazione rischia di generare una perdita stimata di almeno 13.000 euro in dieci anni per i percettori.
Trenta anni di potere d’acquisto eroso
Lo studio sottolinea come in tre decenni le pensioni medio-alte abbiano perso oltre un quarto del potere d’acquisto. Una pensione lorda da 10.000 euro al mese, ad esempio, ha subito una contrazione complessiva di circa 180.000 euro, pari all’equivalente di un intero anno di reddito. Un paradosso che, secondo gli esperti, penalizza proprio quei contribuenti che hanno sostenuto maggiormente il sistema con anni di versamenti regolari, trasformando il loro impegno in un fattore di svantaggio.
La perequazione che favorisce i trattamenti minimi
Il meccanismo di perequazione automatica, introdotto per adeguare le pensioni al costo della vita, si è dimostrato più favorevole per gli assegni di importo basso. Negli ultimi trent’anni, i governi che si sono succeduti hanno sistematicamente modulato la rivalutazione a vantaggio delle pensioni minime, penalizzando quelle più elevate. Con la legge di bilancio del 2024, la situazione si è ulteriormente aggravata: per le pensioni superiori a dieci volte il trattamento minimo, la rivalutazione è stata ridotta al 32% nel 2023 e scesa ulteriormente al 22% nel 2024, con effetti concreti sulla capacità di spesa dei beneficiari.
Il peso fiscale e il contributo dei pensionati
Un altro dato rilevante è che 1,8 milioni di pensionati, meno del 14% del totale, sostengono quasi la metà dell’intero gettito IRPEF generato dalla categoria. Si tratta dei contribuenti più fedeli, quelli che hanno versato contributi elevati per tutta la vita lavorativa, e che ora risultano essere i più colpiti dal blocco della rivalutazione. Al contrario, milioni di pensionati con assegni molto bassi hanno ricevuto rivalutazioni integrali, in alcuni casi superiori al 100%. Questo squilibrio alimenta la percezione di una profonda disparità, con un effetto negativo sulla fiducia nel patto previdenziale tra Stato e cittadini.
Una questione di equità generazionale
Gli esperti avvertono che le attuali politiche rischiano di avere conseguenze anche sulle nuove generazioni. Colpire chi ha versato contributi per 40 anni o più manda il segnale che l’impegno futuro potrebbe non essere tutelato, aumentando la sfiducia dei giovani verso il sistema previdenziale. La svalutazione delle pensioni medio-alte, unita all’elevata pressione fiscale, potrebbe favorire la fuga di talenti all’estero e minare ulteriormente il patto intergenerazionale. L’uso della perequazione come strumento di bilancio, definito da alcuni come una forma di “prelievo forzoso”, mette in discussione la stabilità e la sostenibilità del sistema nel lungo periodo.